HOME
La
traccia©
Copyright I.C.P. e Antonio D’Arienzo
tratto
dall'Abstract di "La
traccia: dal sopralluogo al verdetto"
e da "Pregi
e limiti dell'Indagine Grafodocumentale",
rispettivamente pubblicati nel mese di maggio 2002 (ISBN
88-87975-06-X) e nel mese di maggio 2009 (ISBN-978-88-87975-07-9)
La
criminalistica non è una scienza a sé stante, bensì
è l’applicazione di procedure scientifiche e di
tecniche, talune semplici come la fotografia e altre abbastanza
evolute come quelle nucleari, tutte volte ad identificare l’autore
di un reato, ad accertare le cause, l’epoca, i mezzi di un
evento criminoso e talvolta anche a prevenirlo. Elemento cardine
della criminalistica è la “traccia”,
quell’informatore silenzioso e incorruttibile senza il quale
nessuna indagine può avere alcuna speranza di successo.
La
traccia, nella genericità del termine e negli infiniti aspetti
che può assumere, è muta, ma diventa eloquente quando
l’investigatore, con la propria esperienza, riesce a trarre da
essa quelle informazioni preziose che possono inchiodare il reo alle
proprie responsabilità; a volte una traccia che a prima vista
appare insignificante, poi può rivelarsi risolutiva per le
indagini.
Con
il termine “traccia” ci si riferisce comunemente a
qualsiasi segno lasciato da un corpo materiale, che costituisce la
prova del suo passaggio, e per estensione può essere intesa
come ogni vestigio che dimostri il compimento di un evento. Le
“tracce” non sempre sono materiali: è il caso di
quelle vocali. Le tracce, se possibile, vanno prelevate e custodite,
ma in numerosi casi è sufficiente fotografarle. La fotografia
è ancora un mezzo insostituibile per “portare” la
traccia nel dibattimento, perché non sempre è
sufficiente relazionare un fatto o descrivere un luogo.
Le
figure qui riprodotte sono un campione delle infinite tracce che
quotidianamente sono sottoposte ad esame dagli investigatori.
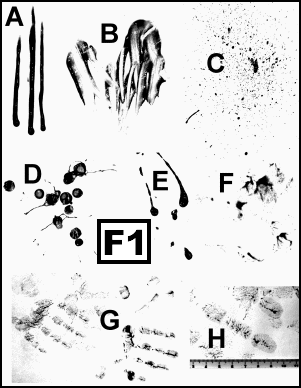 F1.
Vari tipi di tracce ematiche: A) colatura (si dirigono parallele
verso il basso per effetto della forza di gravità); B)
trascinamento (si osservano striature); C) schizzi (hanno uguale
provenienza e alcune tracce sono puntiformi); D) gocciolatura (si
determinano rimbalzi attorno alle gocce più consistenti); E)
falsi spruzzi (diverse direzioni delle singole tracce); F)
imbrattamento (macchie disordinate, non uguali, non circolari); G)
impronte di mani; H) particolare di “G".
F1.
Vari tipi di tracce ematiche: A) colatura (si dirigono parallele
verso il basso per effetto della forza di gravità); B)
trascinamento (si osservano striature); C) schizzi (hanno uguale
provenienza e alcune tracce sono puntiformi); D) gocciolatura (si
determinano rimbalzi attorno alle gocce più consistenti); E)
falsi spruzzi (diverse direzioni delle singole tracce); F)
imbrattamento (macchie disordinate, non uguali, non circolari); G)
impronte di mani; H) particolare di “G".
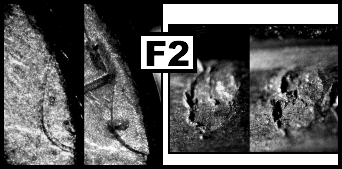 F2.
Esempi di impronte lasciate dall’espulsore (sx) e
dell’estrattore (dx) su due bossoli di cartucce (reperto e
campione sperimentale) esplose con la medesima arma (pistola Beretta
cal. 9 mm Parabellum modello 92 FS). Si tratta di accertamenti
microidentificativi di competenza dell'esperto balistico.
F2.
Esempi di impronte lasciate dall’espulsore (sx) e
dell’estrattore (dx) su due bossoli di cartucce (reperto e
campione sperimentale) esplose con la medesima arma (pistola Beretta
cal. 9 mm Parabellum modello 92 FS). Si tratta di accertamenti
microidentificativi di competenza dell'esperto balistico.
 F3.
Sequenze di una rapina: le immagini così acquisite sono
trasmesse all’autorità giudiziaria che poi procede
all’identificazione della persona ritratta. Si tratta di
accertamenti di natura antroposomatica.
F3.
Sequenze di una rapina: le immagini così acquisite sono
trasmesse all’autorità giudiziaria che poi procede
all’identificazione della persona ritratta. Si tratta di
accertamenti di natura antroposomatica.
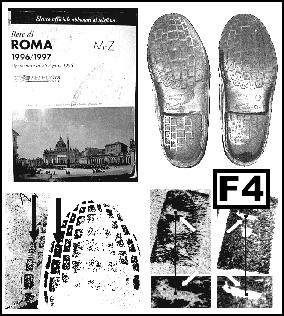 F4.
Un elenco telefonico calpestato da un intruso, rinvenuto sul
pavimento di un ufficio. Sulla copertina si osserva l’impronta
lasciata dalla suola di gomma di una scarpa sinistra. Seguono le
fotografie delle due scarpe sinistre dello stesso modello
appartenenti a due possibili sospetti e le relative impronte. Solo
una di esse presenta un elemento caratteristico che individua non
solo il tipo e il modello, bensì l’esemplare della
scarpa calzata dal malvivente.
F4.
Un elenco telefonico calpestato da un intruso, rinvenuto sul
pavimento di un ufficio. Sulla copertina si osserva l’impronta
lasciata dalla suola di gomma di una scarpa sinistra. Seguono le
fotografie delle due scarpe sinistre dello stesso modello
appartenenti a due possibili sospetti e le relative impronte. Solo
una di esse presenta un elemento caratteristico che individua non
solo il tipo e il modello, bensì l’esemplare della
scarpa calzata dal malvivente.
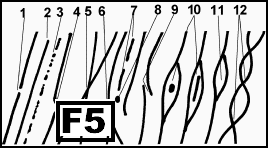 F5.
I caratteri particolari delle impronte dermiche (delle quali si
occupa la dattiloscopia) sono rappresentati dal tipo e dalla
posizione di contrassegni caratteristici, i cosiddetti punti di
identità, che comprendono: 1) interruzioni; 2) estremi (inizi
o termini di “linee” o “tratti”); 3)
interlinee (rilievi con soluzioni di continuità, fra due linee
parallele); 4) uncini (in estremi di linee); 5) incroci (tra due
linee); 6) biforcazioni; 7) tratti (piccoli frammenti di linee fra
altre linee parallele); 8) punti (come il precedente, con la
differenza che si tratta di un punto e non di un segmento); 9)
deviazioni; 10) isolotti (tratti o punti contenuti in figure chiuse);
11) occhielli o occhi (figure chiuse, vuote); 12) intrecci (linee che
si intersecano, formando serie di occhielli). Sono di competenza
dell'esperto dattiloscopico.
F5.
I caratteri particolari delle impronte dermiche (delle quali si
occupa la dattiloscopia) sono rappresentati dal tipo e dalla
posizione di contrassegni caratteristici, i cosiddetti punti di
identità, che comprendono: 1) interruzioni; 2) estremi (inizi
o termini di “linee” o “tratti”); 3)
interlinee (rilievi con soluzioni di continuità, fra due linee
parallele); 4) uncini (in estremi di linee); 5) incroci (tra due
linee); 6) biforcazioni; 7) tratti (piccoli frammenti di linee fra
altre linee parallele); 8) punti (come il precedente, con la
differenza che si tratta di un punto e non di un segmento); 9)
deviazioni; 10) isolotti (tratti o punti contenuti in figure chiuse);
11) occhielli o occhi (figure chiuse, vuote); 12) intrecci (linee che
si intersecano, formando serie di occhielli). Sono di competenza
dell'esperto dattiloscopico.
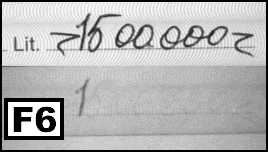 F6.
La contraffazione di un assegno svelata dalla fotografia con la
tecnica dell'infrarosso: L'importo in cifre dell'assegno, che in
origine era di "500.000", è stato trasformato in
"1.500.000" aggiungendo una cifra "1". Con la
tecnica dell'infrarosso, si constata la diversità di
inchiostro del tracciato della cifra "1" rispetto alle
restanti cifre sul La contraffazione di un assegno svelata dalla
fotografia con la tecnica dell’infrarosso: l’importo in
cifre dell’assegno, che in origine era di “500.000”,
è stato modificato in “1.500.000” inserendo la
cifra “1”. Con la tecnica dell’infrarosso, si
constata la diversità dell’inchiostro della cifra “1”
rispetto a quello della penna usata per tracciare le altre cifre.
Sono esami di natura grafodocumentale che possono essere eseguiti, se
fornito sia della necessaria competenza sia dell'idonea attrezzatura,
dal consulente in analisi e comparazione della grafia.
F6.
La contraffazione di un assegno svelata dalla fotografia con la
tecnica dell'infrarosso: L'importo in cifre dell'assegno, che in
origine era di "500.000", è stato trasformato in
"1.500.000" aggiungendo una cifra "1". Con la
tecnica dell'infrarosso, si constata la diversità di
inchiostro del tracciato della cifra "1" rispetto alle
restanti cifre sul La contraffazione di un assegno svelata dalla
fotografia con la tecnica dell’infrarosso: l’importo in
cifre dell’assegno, che in origine era di “500.000”,
è stato modificato in “1.500.000” inserendo la
cifra “1”. Con la tecnica dell’infrarosso, si
constata la diversità dell’inchiostro della cifra “1”
rispetto a quello della penna usata per tracciare le altre cifre.
Sono esami di natura grafodocumentale che possono essere eseguiti, se
fornito sia della necessaria competenza sia dell'idonea attrezzatura,
dal consulente in analisi e comparazione della grafia.
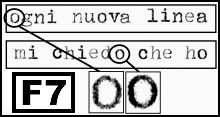 F7.
Nella figura a lato, sopra, parole tratte da un documento; sotto,
altre parole tratte da un altro dattiloscritto; infine, confronto fra
le lettere “o” relative ai due documenti.
L’introflessione del lato sinistro delle “o”
dimostra l’unica provenienza dei due dattiloscritti. Come al
punto F6, la competenza può essere anche per perito grafico.
F7.
Nella figura a lato, sopra, parole tratte da un documento; sotto,
altre parole tratte da un altro dattiloscritto; infine, confronto fra
le lettere “o” relative ai due documenti.
L’introflessione del lato sinistro delle “o”
dimostra l’unica provenienza dei due dattiloscritti. Come al
punto F6, la competenza può essere anche per perito grafico.
 F8.
Nella figura, a sinistra il particolare di una pistola recante la
matricola asportata con la punta di un trapano; al centro,
particolare ingrandito della contraffazione: essendo stato asportato
in profondità lo strato di metallo su cui fu apposta la
matricola, che non è stata identificata; a destra, particolare
delle fasi finali di rigenerazione di una matricola abrasa con una
lima (prima dell’operazione di ripristino, sull’arma si
osservava soltanto il solco prodotto dalla lima.
F8.
Nella figura, a sinistra il particolare di una pistola recante la
matricola asportata con la punta di un trapano; al centro,
particolare ingrandito della contraffazione: essendo stato asportato
in profondità lo strato di metallo su cui fu apposta la
matricola, che non è stata identificata; a destra, particolare
delle fasi finali di rigenerazione di una matricola abrasa con una
lima (prima dell’operazione di ripristino, sull’arma si
osservava soltanto il solco prodotto dalla lima.
F9.
Applicazioni
della microscopia. A- Ricomposizione di due frammenti di un foglio di
giornale, uno rinvenuto sul luogo del reato e l’altro addosso
all’indagato. Con lo stereomicroscopio qui riprodotto,
l’immagine osservata può essere visualizzata sul monitor
o inviata al computer. Il piano di appoggio è un
diafanoscopio, che consente di osservare il reperto cartaceo per
trasparenza. B- Minuti tratti di penna illuminati con un fascio di
luce semiradente, osservati con un microscopio sul quale è
applicata una videocamera collegata al computer. I particolari
ripresi si osservano in basso nella figura “F9-B”, a
minore (sx) e a maggiore (dx) ingrandimento. C- Attraverso l’esame
microscopico è stato accertato che una sottoscrizione era
stata ricalcata dal falsario con una penna a sfera, sopra il
tracciato di una firma autentica riportata sulla carta con una
stampante a getto di inchiostro. La microscopia trova pure
applicazione nella ricerca della successione cronologica dei tratti
che si intersecano.
Seguono,
da sinistra a destra, figure F9-A, F9-B e F9-C.
F9-A F9-B
F9-B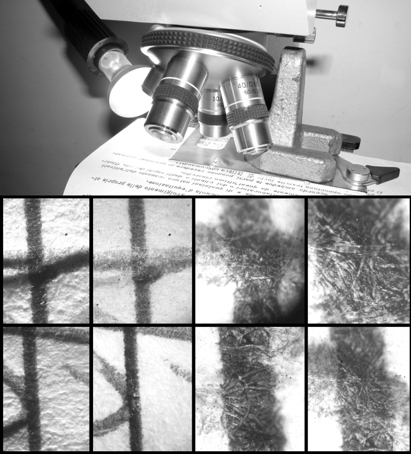 F9-C
F9-C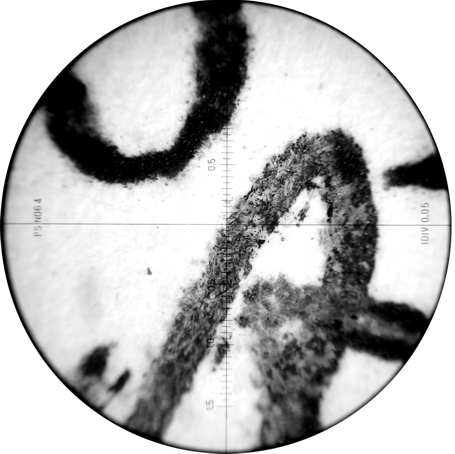
F10.
Le “tracce” non sempre
sono materiali: è il caso delle “tracce” vocali.
Nelle figure, rappresentazioni grafiche di segnali acustici
estrapolati , nel corso di una perizia fonica destinata al
riconoscimento del parlatore , dai file audio acquisiti nel corso di
una intercettazione ambientale. Le trascrizioni delle intercettazioni
ambientali sono spesso incomprensibili in quanto al linguaggio
parlato di aggiunge quello gestuale, naturalmente assente nei
dialoghi telefonici.
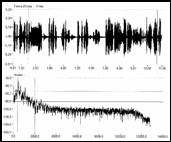
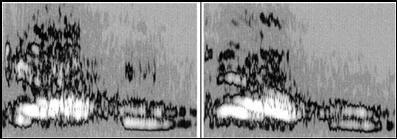
HOME
Trace
Criminalistics
isn’t a stand-alone Science, but the application of many
Scientifical and Technical procedures, some as simple as Photography,
others as advanced as Nuclear, all directed to identify the author of
a crime, to investigate its reasons, times and instruments, sometimes
even preventing it. Pivotal element of criminalistics is the trace,
that silent and incorruptible informer without it no investigation
can anyway succeed.
Trace,
in the vagueness of the word, and in its countless aspects, is
silent, but can deliver information when the investigator, by his
expericence, can extract the precious informations that can pack up a
guilty. Sometimes a trace apparently insignificant, can be unvaluable
for the investigation.
With
the word trace, we commonly refer to every sign left by a physical
body, being the proof of its passage, and by extension every sign
that is a proof of the happening of an event. Trace isn’t
necessarly physical: the voice isn’t. Trace, when possible,
must be recovered and set in safe custody, but in many cases a
photographic record is enough. Photography is still an unvaluable
method to bring a trace to the Court, because a written report is
often non sufficient to describe an event or a site.
Figures
here reproduced are an example of the countless traces that can have
interest in a Court, during a trial.
F1.
Various types of hematic traces.
A)
trickling (directed downwards, following gravity); B) drag (streaks
are seen); C) squirting (same origin, some traces are dots); D)
dripping (bigger drops splash around); E) false squirting (too much
substance, single traces with different orientation); F) blotting
(dots randomized, in shape and dimension); G) hand impressions; H)
detail of G.
F2.
Samples of the imprints on the ejector (left) and on the extractor
(right) on a spent cartridge case (evidence and sample), exploded
with a cal. 9 Parabellum Beretta 92 FS.
F3.
Sequence of a robbery. Images adquired can be sent to the prosecutor,
who can proceed to identify the subject.
F4.
A phone list trampled by an intruder, recovered in a office floor. On
the cover is evident a footwear impression. Following, the images of
the shoes, and the impressions, owned by two possible suspects. Only
one presents a feature that identifies not the model, but the single
shoe.
F5.
Details of fingerprints, represented by the type and the position of
classifiable characteristics, the so called points of identity,
including: 1) divides, 2) endings, 3) indipendent lines, 4) hooks (on
line endings), 5) crosses (between two lines), 6) bifurcations, 7)
tracts (fragments of lines between two parallel lines), 8) points (as
before, but an effective point, not a segment); 9) detours, 10)
islands (points in closed figures), 11) lakes (closed lines, without
points or lines inside), 12) interlacings.
F6.
Check forgery, revealed by infrared photography. The original sum,
500.000, was transformed in 1.500.000, adding a 1. The infrared
photography can differentiate the inks between original writing and
added writing.
F7.
Words from two typewrittwen documents; matching of the letters o in
the two documents (questioned and sample). The left side introflexion
of the letter, same in both documents, is the proof of the same
origin of the two typescripts.
F8.
On the left a detail from an automatic pistol, with the serial number
deeply drilled; on the center, enlarged detail of the same (being
deeply carved, serial number isn’t recoverable, anyway); on the
right, detail of a phase of the regeneration of a filed serial
number (before the regeneration process, on the firearm only the file
grooves are seen).
Informative
site about forensic sciences, with technical notes about crime
sciences, drawn from the collected essays of Antonio D’Arienzo,
essays and commentaries from experts in criminalistics, law and
technical investigation.
HOME
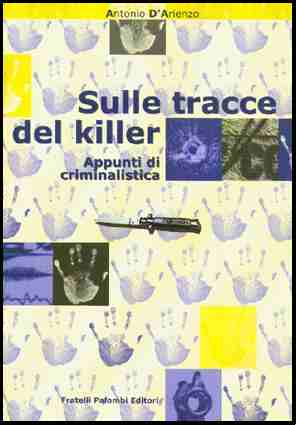

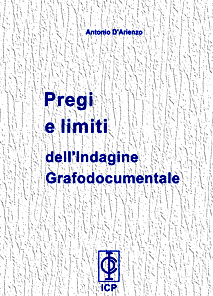
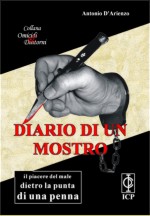
"Sulle
tracce del killer - Appunti di criminalistica" ISBN-8876219293
- "Abstract di: La traccia: dal sopralluogo al verdetto"
ISBN 88-87975-06-X - "Pregi e limiti dell'Indagine
Grafodocumentale" ISBN-978-88-87975-07-9 - "Diario di un
mostro" ISBN 88-87975-01-9, e tra i romanzi
di Antonio D'Arienzo, anche "Un
MAriTo per tutte",
edito da ICP, e numerosi mini romanzi, tra cui "I
due vagabondi".
Note sull'Autore
 Antonio
D’Arienzo ha iniziato ad occuparsi di criminalistica da
giovanissimo, collaborando con famosi esperti che sono stati i suoi
maestri, tra cui Vacchiano, Sorrentino e, naturalmente, il padre,
Pietro, con il quale ha, tra l’altro, seguito lo storico
processo per la strage di Piazza Fontana. Ha poi preso parte con
sempre appassionato impegno, in qualità di consulente tecnico,
ai più importanti casi giudiziari italiani degli ultimi
trent’anni, dall’omicidio di Via Poma, alle
intercettazioni del bar Mandara, all’omicidio dell’Università
La Sapienza di Roma, al caso della moschea Al Harmini, al più
recente delitto di Perugia, passando per la strage del treno 904.
Antonio
D’Arienzo ha iniziato ad occuparsi di criminalistica da
giovanissimo, collaborando con famosi esperti che sono stati i suoi
maestri, tra cui Vacchiano, Sorrentino e, naturalmente, il padre,
Pietro, con il quale ha, tra l’altro, seguito lo storico
processo per la strage di Piazza Fontana. Ha poi preso parte con
sempre appassionato impegno, in qualità di consulente tecnico,
ai più importanti casi giudiziari italiani degli ultimi
trent’anni, dall’omicidio di Via Poma, alle
intercettazioni del bar Mandara, all’omicidio dell’Università
La Sapienza di Roma, al caso della moschea Al Harmini, al più
recente delitto di Perugia, passando per la strage del treno 904.
È
investigatore privato e consulente del Tribunale di Roma, nonché
autore di numerosi articoli ed interventi su riviste giuridiche e
scientifiche, di trattati tecnico-giuridici, spaziando dall’indagine
grafica alla balistica fino all’antroposomatica, ed altre
opere, romanzi fantastici e noir, questi ultimi ispirati dal contatto
professionale col mondo del crimine e nei quali ha riversato
esperienze, confessioni e testimonianze raccolte negli anni.
e-mail
info@infocrim.com
- cell. 3476690511 -
Studio Via Pietro Aretino n. 69 - 00137 Roma
HOME
In corso di
inserimento
particelle
ternarie particelle binarie Sb Ba Pb microanalisi microscopia
elettronica abbinata alla microanalisi a dispersione di raggi X
impronta latente vapori di cianacrilato cianoacrilato ninidrina
esaltazione delle impronte analisi per attivazione neutronica
assorbimento atomico tecniche applicabili in caso di omicidio
suicidio con armi da sparo armi da fuoco munizioni cartucce
contenenti nell’innesco e non nella carica di lancio o polvere
da sparo tecniche dell’infrarosso termico e infrarosso riflesso
ultravioletto sulla perizia o consulenza grafica o di analisi e
comparazione della grafia che si basa sulla indagine grafonomica o
metodo grafonomico o perizia grafologica che si basa sulla grafologia
che superano e integrano la perizia calligrafica e quella
grafometrica sulla perizia fonica o di riconoscimento vocale sulla
dattiloscopica impronte papillari impronte digitali indagine somatica
indagine antropometrica antropometria sulla perizia balistica su armi
munizioni esplosivi materie esplodenti sui residui dello sparo GSR
acronimo di Gun Shot Residues residui di colpo d’arma da fuoco
guanto guanto di paraffina tematiche criminologiche criminologia
medico legali medicina legale sulla procedura peritale presso il
tribunale la corte di assise corte di appello civile penale suprema
corte di cassazione note giurisprudenziali giurisprudenza sentenze di
merito Le parti di ogni elemento di scrittura lettera, cifra, ecc.
assumono nomi diversi a seconda della loro forma e struttura. La
parola prescelta, Sfogliata , contiene lettere con allungo superiore
e allungo inferiore, occhielli e asole, tagli, paraffi volutamente
esagerati per meglio rendere l’idea di ciò che si vuole
rappresentare. In particolare: 1 e 10: paraffo iniziale e finale 2:
allungo superiore che si inserisce nella zona superiore della
triplice ripartizione della scrittura 3: allungo inferiore che si
inserisce nella zona inferiore 4: occhiello 5: asola 6: esempio di
asola estremamente stretta tanto da identificarsi nell’asta 7:
puntino della i 8: filetto tratto ascendente 9: asta tratto
discendente 11: esempio di striature relative alla rotazione della
penna a sfera 12: esempio di sutura col termine sutura ci si
riferisce a quel punto del tracciato in cui la penna prima si stacca
dalla carta e poi riprende il tracciamento si tratta di una soluzione
di continuità lungo un segmento grafico apparentemente privo
di interruzione in corrispondenza della sutura generalmente si
osserva, dal retro del foglio e con luce radente, la maggior
pressione determinata dalla penna in fase di attacco e anche la
variazione di pressione tra i rami del tratto suturato sono diverse
le variazioni di pressione in corrispondenza dei tratti curvi e
stretti, dove, soprattutto con le biro, si riconosce una brusca
variazione della rotazione della sfera, tuttavia senza sutura 13:
taglio della t 14: riccio 15: estremo di tratto quello finale
generalmente è appuntito e può presentare uncini quello
iniziale spesso è caratterizzato da un maggior deposito di
inchiostro 16: esempio di occhiello suddiviso in più settori
17: collegamento 18: raccordo tratto orizzontale 19: asse della
lettera 20 e 21: linee che separano la zona centrale relativa al
corpo della lettera dalla zona superiore sede delle limitanti
superiori e dalla zona inferiore relativa alle limitanti inferiori la
linea 21 segnala la linea o l’allineamento di base Tra i
caratteri generali più rilevanti ai fini identificativi della
grafia, segnalo: il livello grafico o capacità grafica , cioè
l’attitudine di una persona a far uso della penna si tratta del
carattere grafico più importante. Un soggetto dotato di buona
capacità grafica può simularne una scadente invece, chi
ha scarsa attitudine all’uso del mezzo scrittorio, non riesce a
eseguire una scrittura evoluta l’impostazione grafica, cioè
il modo con cui la scrittura viene inserita nel foglio e come lo
occupa quindi, anche le marginature rispetto alle estremità
del foglio o di eventuali margini prestampati , nonché il tipo
di mezzo scrittorio adoperato ed altri elementi tipici che
caratterizzano quella specifica grafia lo stile della scrittura la
grafia può essere calligrafica, corsiva, a stampatello, ecc.
Tanto più si allontana dal modello scolastico, maggiormente
essa è personalizzata naturalmente, i segni grafici si
riferiscono ad uguali modelli, perché, in caso contrario,
nessuno capirebbe la scrittura di un altro. Acquisita una certa
personalizzazione, la grafia di un individuo, pur seguendo la sua
evoluzione o involuzione, mantiene pressoché inalterate nel
tempo le caratteristiche morfostrutturali dei segni lo sviluppo del
curvilineo e la presenza di angolosità le dimensioni delle
scritture, che possono essere piccole, medie o grandi le dimensioni
spesso sono solo indicative perché soggette alla postura di
chi scrive e allo spazio di scrittura determinato da margini fisici o
prestampati: si consideri chi compila un modulo o un bollettino
postale, che si trova obbligato a scrivere con dimensioni che possono
non essere le sue abituali le proporzioni tra le lettere, tra le
parole e tra i singoli segni grafici nell’ambito di una
medesima lettera o cifra la pendenza assiale delle lettere e delle
cifre, cioè l’inclinazione di esse rispetto alla riga di
base l’allineamento di base l’allineamento degli apici o
limitante superiore la fittezza tra le lettere la spaziatura o
larghezza tra le parole la distanza tra le righe la pressione grafica
pure questa soggetta alla postura: si consideri, ad esempio, la
scrittura di una persona allettata . I valori angolari dei tratti
finali di parola, la presenza o meno di tratti, di punti non
giustificabili con la punteggiatura, l’intersezione di lettere,
il raddoppio di alcuni segni, ritocchi, correzioni, tremolii, macchie
e riprese abituali non accidentali del tracciato, vanno tutti
interpretati come caratteri generali della grafia così anche
la presenza costante di sigle, crasi, forme abbreviate, con o senza
punto d’interpunzione, segni di ornamento, errori ortografici,
soprattutto se si ripetono nelle parole omografe la punteggiatura
rilevante nel caso di un eccessivo uso dei punti d’interpunzione
o l’assenza o l’errato inserimento degli stessi Tra i
caratteri particolari, cioè quegli elementi della scrittura
che possono riguardare solo alcune parti di essa, i più
rilevanti sono: la forma dei segni o la loro struttura ad esempio, la
sagoma o la costruzione di lettere e cifre omografe, dei collegamenti
tra lettere omografe o affini, la forma e la posizione dei punti
d’interpunzione la forma di alcuni segni che compongono le
lettere composte quali i tagli delle t la forma, la struttura e le
dimensioni degli occhielli i forestierismi o xenismi la posizione di
punti, apostrofi o accenti i raccordi linee curve o dritte di
collegamento tra filetti ed aste i risvolti la sezione curva che può
osservarsi in alcune lettere, superiormente o inferiormente gli
accessori elementi di completamento delle lettere, previsti dal
modello standard, quali il taglio della t ed il puntino della i ,
questi pure rientranti tra le peculiarità istintive, i
cosiddetti gesti fuggitivi i paraffi segni preparatori del filetto
iniziale della prima lettera di una parola o i prolungamenti del
tratto finale dell’ultima, spesso identificabili nei ricci
maggiormente vistosi le astine i ricci costituiti generalmente da
piccoli ganci nei punti di attacco e di stacco della penna le sedi
delle interruzioni interletterali in parole o in gruppi di lettere
omografi. L’esame per spettrofotometria di assorbimento atomico
si principia sul fatto che un solido, riscaldato all’incandescenza,
emette uno spettro continuo, rilevabile con opportuna strumentazione.
Nel caso di ricerca di residui di sparo, l’indagine interessa
alcuni metalli, significativi dell’avvenuto sparo, quali il
bario Ba , l’antimonio Sb ed il piombo Pb , riferibili
all’innesco delle cartucce, composto prevalentemente da sali di
piombo azotidrato o stifnato di piombo, miscelato a limitate quantità
di solfuro di antimonio e nitrato di bario agglomerato agglomerati
particelle sferiche micron μ Sono armi da sparo tutti quegli
strumenti che lanciano un oggetto proiettile attraverso un tubo canna
. Sono da fuoco se il lancio avviene per la spinta ricevuta dal
proiettile in conseguenza dell’espansione di gas che si
producono successivamente alla deflagrazione di una sostanza
esplosiva carica di lancio , a sua volta innescata dall’esplosione
di un’altra sostanza esplosiva miscela innescante Proiettile,
carica di lancio ed innesco fanno parte della cartuccia La cartuccia
delle armi moderne è fornita di un contenitore metallico
bossolo , tappato ad un’estremità dal proiettile. La
carica di lancio è all’interno del bossolo.
Nell’estremità opposta a dove ha sede il proiettile c’è
la miscela innescante, che può essere applicata internamente
al bossolo in munizioni per armi a percussione laterale, come le
calibro .22 o in un contenitore esterno al bossolo capsula di innesco
, in armi a percussione centrale Il lancio del proiettile e di quelli
cosiddetti secondari avviene dalla bocca della canna e, tenuto conto
della loro notevole velocità, vengono lanciati a distanza I
residui di sparo, naturalmente, essendo piccoli e leggeri vengono
stoppati dall’aria molto prima del proiettile, tranne un’esigua
quantità che segue il proiettile e rimane protetta dallo
stesso lungo la traiettoria. Questo non vuol dire che rimangano in
prossimità della canna I residui di sparo che raggiungono le
mani dello sparatore oppure i suoi indumenti o gli ambienti
circostanti, provengono dal punto di sfiato che, nelle armi ad
alimentazione semiautomatica, è quello del punto di chiusura,
ossia dove l’otturatore blocca il fondello della cartuccia, che
però si apre quando viene espulso il bossolo per far spazio ad
una nuova cartuccia. Nelle armi a rotazione è lo spazio
compreso fra il piano posteriore del tamburo e il castello della
rivoltella, dove fuoriesce la punta del percussore Nelle armi a
chiusura geometrica nelle quali la canna arretra nell’istante
successivo allo sparo il rilascio di residui di sparo è
inferiore a quanto non avvenga con le altre armi. Sebbene le
rivoltelle siano di fatto senza chiusura, non necessariamente
rilasciano più residui rispetto alle armi automatiche, in
quanto il bossolo non viene espulso dopo lo sparo, ma resta vincolato
all’interno della camera di scoppio praticata nel tamburo. Nei
fucili da caccia non automatici doppietta , il rilascio è
pressoché inesistente in quanto la canna resta vincolata al
castello anche dopo lo sparo notevole, invece, per i fucili da caccia
automatici Nella figura n. 2 si osservano, in alto, un fucile da
caccia tipo giustapposto, non automatico, ed una pistola
mitragliatrice, ossia ad alimentazione automatica, però
predisposta pure per sparare a raffica in basso, nella medesima
figura, una rivoltella vista di profilo, col tamburo ribaltato
all’esterno, e di lato ed una pistola ad alimentazione
automatica, non predisposta per la raffica cioè lo sparo di
più colpi agendo una sola volta sul grilletto Nella figura n.
4 si osserva la posizione della cartuccia, di profilo, all’interno
della canna nella figura n. 5, a sinistra, il fondello del bossolo
che sporge dal vivo di culatta della canna e, a destra, vincolato
all’otturatore dall’estrattore, dopo lo sparo, un istante
prima che per effetto dell’espulsore, per far posto nella canna
ad una nuova cartuccia, venga lanciato esternamente dall’arma
attraverso la stessa apertura che funge da punto di sfiato dei
residui di sparo. Nelle figure 6, 7, 8, 9 e 10, rispettivamente
vengono riprodotti: una cartuccia integra e suddivisa nei componenti
principali, radiografie di cartucce calibro .38 e .22 Long Rifle, un
bossolo, prima e dopo essere sezionato, e una capsula di innesco per
arma a percussione centrale che manca nelle armi a percussione
laterale, nel qual caso nel bossolo non si rileva posteriormente
quella cavità che nella figura 9 si osserva in basso, al
centro del fondello mappatura Con la tecnica cosiddetta dello stub ,
senza la possibilità di una precisa mappatura della superficie
sottoposta a prelievo, molti dati non possono essere accertati, e tra
questi neanche se le mani degli imputati fossero state o meno lavate
prima del prelievo Nella figura è tratteggiata la zona
cosiddetta elettiva della mano di chi impugna l’arma. È
in quella piccola superficie della mano dove si depositano i maggiori
residui di sparo in conseguenza dello stesso I residui, naturalmente,
sono tanto più concentrati quanto più la zona della
mano sottoposta ad esame è prossima al punto di sfiato dei gas
che, nelle pistole ad alimentazione automatica, corrisponde al punto
di chiusura dell’arma, mentre nelle rivoltelle corrisponde
all’estremità posteriore del tamburo Si osservi anche la
tavola n. 8, in cui si constata la rarefazione dei residui più
si è distanti dalla zona di sfiato dei gas polizia di stato
guardia di finanza arma dei carabinieri tracce e ultratracce reattore
nucleare polizia scientifica catalogo nazionale delle armi comuni da
sparo commissione consultiva centrale per il controllo delle armi
collegamenti in corso
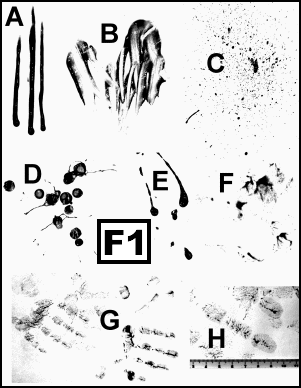 F1.
Vari tipi di tracce ematiche: A) colatura (si dirigono parallele
verso il basso per effetto della forza di gravità); B)
trascinamento (si osservano striature); C) schizzi (hanno uguale
provenienza e alcune tracce sono puntiformi); D) gocciolatura (si
determinano rimbalzi attorno alle gocce più consistenti); E)
falsi spruzzi (diverse direzioni delle singole tracce); F)
imbrattamento (macchie disordinate, non uguali, non circolari); G)
impronte di mani; H) particolare di “G".
F1.
Vari tipi di tracce ematiche: A) colatura (si dirigono parallele
verso il basso per effetto della forza di gravità); B)
trascinamento (si osservano striature); C) schizzi (hanno uguale
provenienza e alcune tracce sono puntiformi); D) gocciolatura (si
determinano rimbalzi attorno alle gocce più consistenti); E)
falsi spruzzi (diverse direzioni delle singole tracce); F)
imbrattamento (macchie disordinate, non uguali, non circolari); G)
impronte di mani; H) particolare di “G".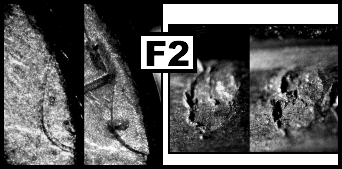

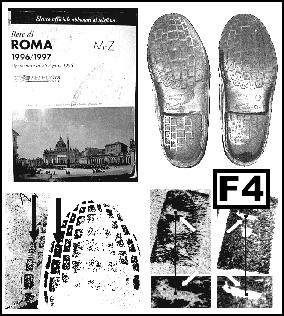
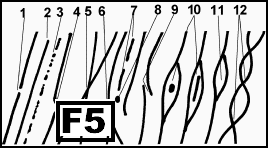
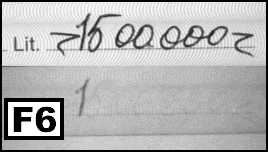
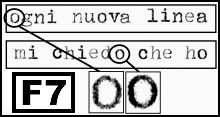

 F9-B
F9-B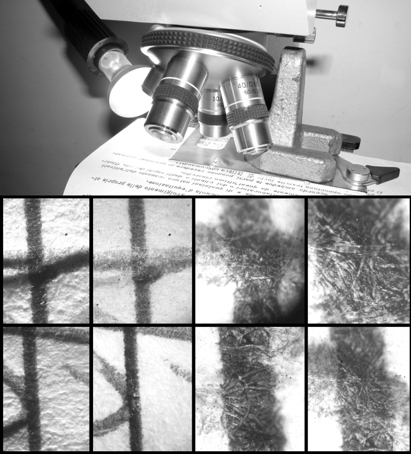 F9-C
F9-C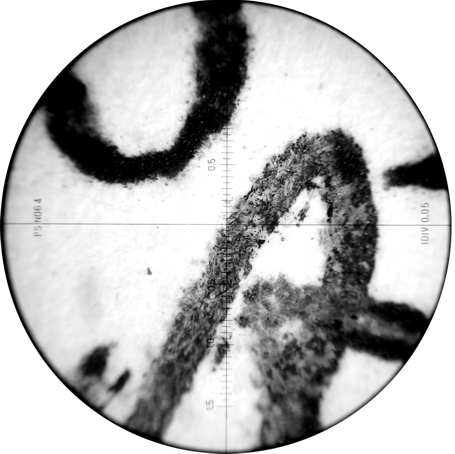
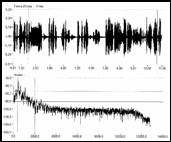
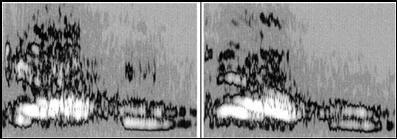
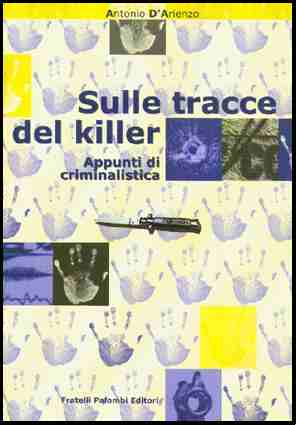

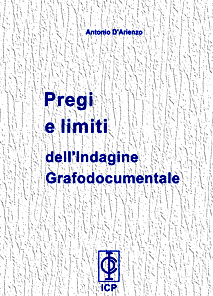
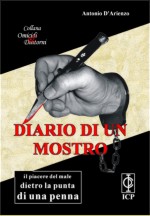
 Antonio
D’Arienzo ha iniziato ad occuparsi di criminalistica da
giovanissimo, collaborando con famosi esperti che sono stati i suoi
maestri, tra cui Vacchiano, Sorrentino e, naturalmente, il padre,
Pietro, con il quale ha, tra l’altro, seguito lo storico
processo per la strage di Piazza Fontana. Ha poi preso parte con
sempre appassionato impegno, in qualità di consulente tecnico,
ai più importanti casi giudiziari italiani degli ultimi
trent’anni, dall’omicidio di Via Poma, alle
intercettazioni del bar Mandara, all’omicidio dell’Università
La Sapienza di Roma, al caso della moschea Al Harmini, al più
recente delitto di Perugia, passando per la strage del treno 904.
Antonio
D’Arienzo ha iniziato ad occuparsi di criminalistica da
giovanissimo, collaborando con famosi esperti che sono stati i suoi
maestri, tra cui Vacchiano, Sorrentino e, naturalmente, il padre,
Pietro, con il quale ha, tra l’altro, seguito lo storico
processo per la strage di Piazza Fontana. Ha poi preso parte con
sempre appassionato impegno, in qualità di consulente tecnico,
ai più importanti casi giudiziari italiani degli ultimi
trent’anni, dall’omicidio di Via Poma, alle
intercettazioni del bar Mandara, all’omicidio dell’Università
La Sapienza di Roma, al caso della moschea Al Harmini, al più
recente delitto di Perugia, passando per la strage del treno 904.